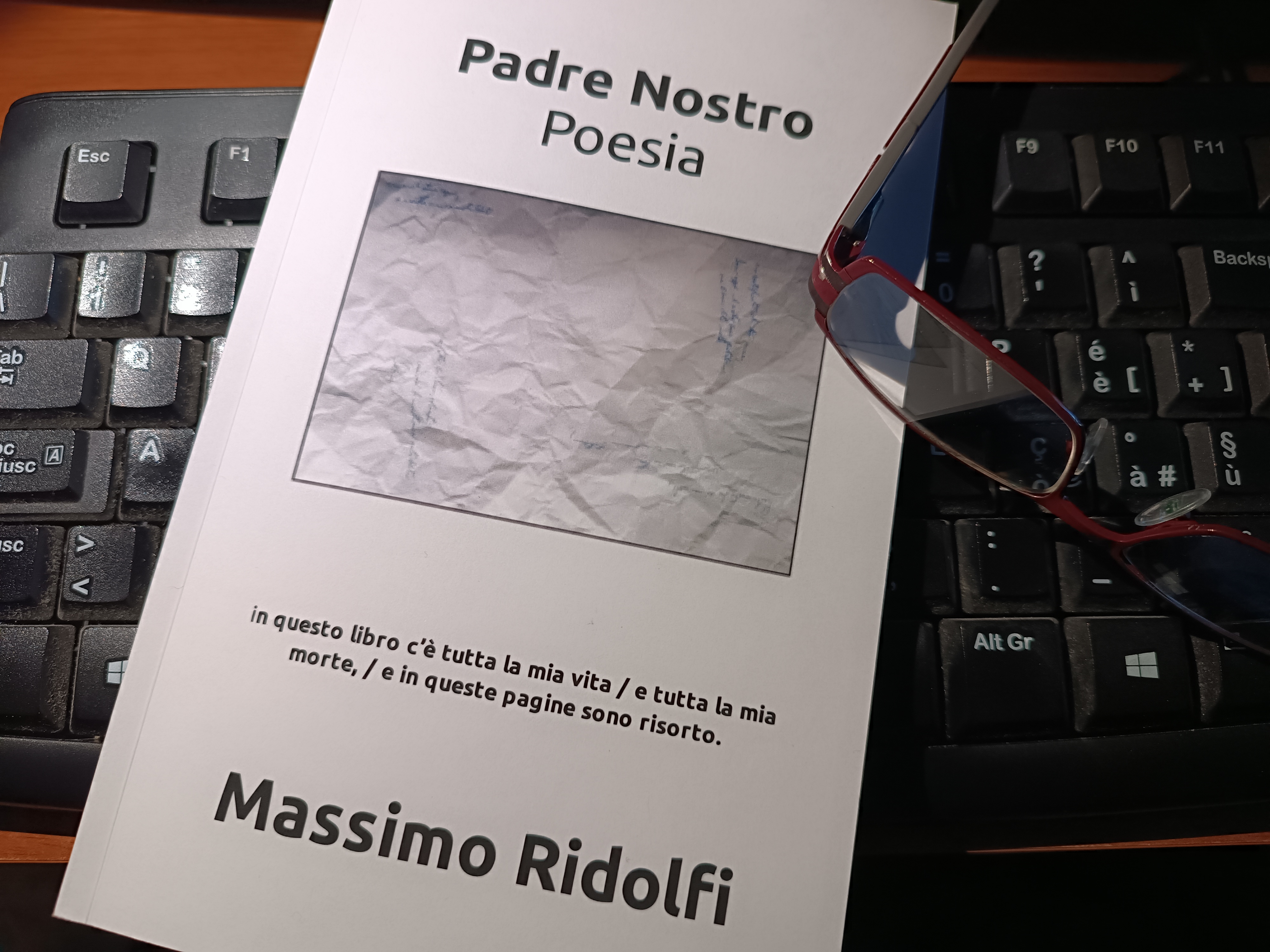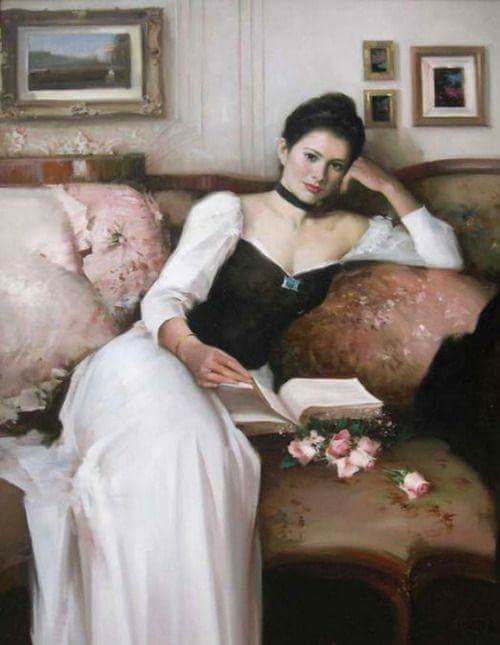versione pdf: Intervista a Francesco Innella sulla raccolta “Kimera – Poesie dell’Io”

Intervista a Francesco Innella sulla raccolta “Kimera – Poesie dell’Io”
a cura di Michele Nigro
Michele Nigro. Perché il titolo “Kimera – Poesie dell’Io”?
Francesco Innella. Prima di scrivere questa raccolta ho pensato di trovare il filo conduttore delle mie poesie e sono arrivato alla conclusione che il mio poetare è stato sempre una ricerca dell’Io. Nella mia poesia ho sempre investigato il ruolo del poeta nel vivere quotidiano. In base a questo principio ho selezionato le poesie contenute in Kimera, che è una aporia: nell’antica filosofia greca con questo termine si indicava l’impossibilità di dare una risposta precisa a un problema, poiché ci si trovava di fronte a due soluzioni che, per quanto opposte, sembravano entrambe valide, ossia – nel nostro caso specifico ̶ senza soluzione dei conflitti dell’Io.
Che cos’è l’ego per l’uomo-poeta Innella? Bisogna conoscerlo per domarlo, educarlo o semplicemente assecondarlo?
Sulla mia concezione dell’ego ti rispondo con un aforisma di Cioran: “Avremmo dovuto essere dispensati dal trascinare un corpo. Bastava il fardello dell’io.” Ma che cosa è l’ego? È la lotta per mantenere un equilibrio precario tra noi e gli altri. È, in effetti, un conflitto. Conoscerlo è impossibile perché tende sempre a cambiare negli atteggiamenti quotidiani. Quindi non si può domare una cosa che muta. Dobbiamo rassegnarci, e ritornando ancora a Cioran: “Siamo costretti all’io, al veleno dell’ego”.
La tua ricerca sull’Io ha origini “antiche”. Non è la prima volta che con la tua poetica esplori e cerchi di ridimensionare l’ipertrofia dell’Io (anche adottando uno stile sobrio per dare l’esempio!), però scegli comunque la parola, strumento di quell’”effimera verbosità” che citi nella poesia Egoità, per comunicare i risultati della tua ricerca a noi lettori. Può la poesia diventare un valido esercizio di auto-eclissamento?
No, assolutamente: oggi si scrive tanto. Il fenomeno è ben evidente sulla rete perché c’è un grande bisogno di “glorificare” l’ego. Si può raggiungere una distanza dall’ego con la poesia impersonale ̶ vedi l’haiku ̶ ma nulla di più.
La Natura ci mette a tacere con i suoi fenomeni, ci rende umili. Perché in seguito dimentichiamo la nostra caducità e ritorniamo a essere arroganti?
Secondo me è tutta colpa dell’antropocentrismo. Concezione secondo cui tutto ciò che è nell’universo è stato creato per l’uomo e per i suoi bisogni, per cui l’uomo si viene a trovare al centro dell’universo e può considerarsi misura di tutte le cose.
La necessità dell’oblio mentre siamo ancora vivi. Perché questo bisogno di annientarsi, di eclissarsi, di perdersi, ritorna spesso nei tuoi versi?
La quiete assoluta è del mondo inorganico, di cui appunto la vita è alterazione. Allora in me prende corpo il principio del nirvana, ossia il ritorno alla quiete, quello che è in fondo il messaggio buddista, ma escludo l’autodistruzione. Il suicidio, secondo Arthur Schopenhauer, è un modo sbagliato di rispondere alle sofferenze della vita.
In Lenimento parli di “antiche presenze” che mormorano: sono ricordi personali dal passato o si tratta di catene interiori tipiche della condizione umana e quindi innate?
Sì, da una parte ci sono i ricordi personali che mi hanno segnato in maniera molto rilevante. Luca Canali, nell’antologia “I poeti della ginestra”, mi descrive come una persona che ha l’animo vulnerato per l’assedio dei suoi simili; dall’altra parte non riesco a superare le catene interiori tipiche della condizione umana, e tutte e due queste situazioni sono evidenti nel mio poetare; mi sento toccato da un’angoscia che ha origini antiche, che ho sempre avvertito e che non si dilegua ma continua nel tempo a sussistere; è una ferita interiore che non guarisce.
Il dolore è solo un’esperienza che causa tristezza o può rivelarsi fonte di energie preziose inutilizzate e da rimettere in gioco per costruire il bene?
Oggi si usa molto la parola resilienza che in psicologia indica la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Io credo che il dolore favorisca la crescita: Aldo Carotenuto, psicoanalista junghiano, ha sempre parlato della ferita interiore come di una feritoia dalla quale osservare il dolore e iniziare il suo superamento e trasformarlo in bene dal momento in cui si è giunti alla consapevolezza della propria dolorosa condizione.
In La luna “uomini in torri d’avorio / sognano illusioni”; forse sono gli stessi esseri umani che come noi percorrono “le strade del nulla” citate nella poesia I gatti. Quali sono queste illusioni e cosa potrebbe contribuire alla nostra liberazione da esse?
Carlo Michelstaedter sostiene che ognuno di noi non riesce a uscire dal cerchio illusorio della vita, ci rinchiudiamo nelle nostre torri d’avorio e scriviamo poesie, siamo noi stessi che coltiviamo la poesia come rimedio al vuoto: io sono poeta perché ho sperimentato il nulla e le sue numerose strade. Difficile definire le illusioni, sono molteplici: ogni essere umano ha le proprie ed è difficile liberarsi da esse; forse, come dice Krishnamurti, dovremmo avere il coraggio di eliminarle e avvertire il vuoto che si nasconde dietro di loro, ma poi si ha il coraggio di affrontare il vuoto? O ci spaventiamo e ci facciamo catturare dalle illusioni che permettono a tutti noi di vivere?
“Il canto si spegne / tra i fatui bagliori / di una esistenza mancata” (Il camino). Quale esistenza abbiamo già mancato o stiamo per mancare?
Tutta la nostra esistenza è una mancanza: se non lo fosse, non avremmo voglia di completarci attraverso la scrittura, o altre esperienze più significative; quando si sperimenta la privazione e si sente il bisogno di esplorare, di tuffarsi nell’indefinito, allora la mancanza viene assorbita dal fare e forse in quel momento si può toccare l’essere, o sfiorarlo almeno.
“… nel mistico silenzio / l’ego si appanna / e tace” (La Via interiore). Come può l’uomo contemporaneo tornare a ricercare, ammesso che voglia ricercarlo, questo mistico silenzio?
L’uomo contemporaneo, tranne poche eccezioni, è assorbito dal frastuono della vita e ascolta i nuovi imbonitori che lo distraggono dalla cosa più essenziale: la conoscenza di sé; quindi parlare di mistico silenzio è una cosa ardua per l’uomo di oggi, se non impossibile. Io ho raggiunto il silenzio in poche occasioni, generalmente dopo la recitazione di un mantra, ma ti posso assicurare che è una cosa difficile e rara da realizzare, e ti dico questo perché non sono un mistico, ma comunque ci ho provato. E l’esperienza del silenzio interiore è totalizzante, ti senti assorbito nel Tutto.
Continua a leggere “Intervista a Francesco Innella sulla raccolta “Kimera – Poesie dell’Io””